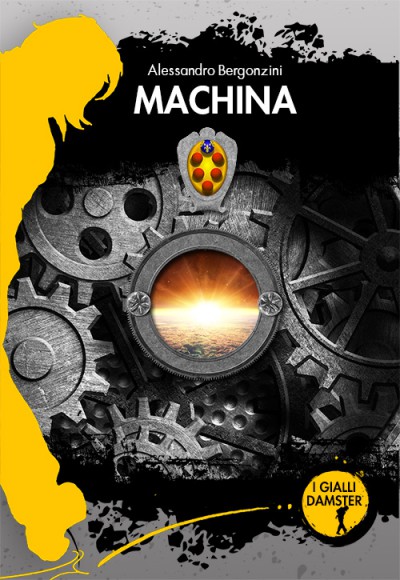MACHINA
Firenze 1492. Lorenzo il Magnifico muore a 43 anni a causa di una malattia che non avrebbe dovuto condurlo ad un simile epilogo. Il suo medico, Pier Leone Leoni, ne è convinto, ma viene trovato morto anch’egli, il giorno immediatamente successivo.
Con la morte del Magnifico, il Papa perde uno dei suoi più fidati consiglieri, l’ago della bilancia nei precari equilibri esistenti fra i vari regni italici, creando un vuoto di potere che stimola l’avidità di Lapo di Piero degli Alberti il quale intravede la possibilità di appropriarsene. A qualunque costo.
Il vescovo Martini inviato ad indagare su una morte tanto imprevedibile quanto anomala, dovrà scoprire la verità nascosta in una selva di intrighi, cospirazioni, vendette, un misterioso veleno, spietati sicari ed il fantomatico Consiglio dei Dieci.
Un’indagine piena di insidie, ricca di colpi di scena che condurrà il vescovo alla scoperta di una sanguinosa faida e di uno straordinario congegno.
Quasi in sordina nascerà l’amore fra due giovani, un contraltare a maniacali disegni criminosi e insane lotte di potere.
Prologo
Finale, ducato di Modena, dominio imperiale estense, 12 gennaio A.D. 1492
Il pallido astro solare si apprestava a svanire oltre l’orizzonte, quasi fuggisse all’avanzare minaccioso di una coltre nebbiosa che aveva iniziato ad avvolgere l’imponente sagoma del castello, presidio e baluardo del confine tra il feudo imperiale e quello pontificio.
Due esili figure, ingrossate ai fianchi da straripanti borsoni di cuoio, si muovevano a passo svelto lungo la massicciata. La fronte di entrambe luccicava del sudore di molte miglia di cammino. I volti stravolti dalla fatica si stagliavano biancastri sugli abiti vellutati, la cui ottima fattura risultava irriconoscibile, quasi fosse stata logorata dalle insidie del precipitoso viaggio. Tuttavia, nel pallore di quei lineamenti si agitavano, vigili, nere pupille che instancabilmente sondavano il terreno circostante e a cui non poté certo sfuggire la mole dei torrioni che svettavano sopra le mura perimetrali del maniero.
Le gambe, che da ore si trascinavano indolenzite, inaspettatamente si erano rimesse a lavorare, attingendo a una riserva di energia, un’ormai insperata iniezione di fiducia, proprio quando anche la speranza sembrava averli abbandonati, inducendoli ad accettare, con assoluta rassegnazione, la prospettiva di trascorrere un’altra notte all’addiaccio.
— Semo salvi! — disse il più vecchio, accompagnando le parole con un sorriso raggiante.
— Speremo… gavemo ris¢ià de rovinar a nostra famegia! — rispose l’altro poco convinto.
— No ghe gera alternative — replicò asciutto, voltandosi infastidito verso il fratello minore con cui aveva già discusso decine di volte di quella questione e, ciononostante, null’altro che una minima parte dei mille e più battibecchi avuti con la moglie e la cognata, nel corso dei quali aveva dovuto difendere strenuamente la decisione di lasciare Murano per trasferirsi a Firenze.
— Dovevimo tirarse indrio — insistette il minore, fermo sulle proprie posizioni.
— Gavaressimo dovesto rinunciar ai nostri sogni?
— Nostri? Tui! — le parole gli uscirono di bocca con involontaria rabbiosità. Il fratello maggiore sospirò stancamente, piegò il capo in avanti, scuotendolo leggermente mentre raccoglieva i pensieri.
— Me sembrava che i gavessimo tutti e do… — replicò pacatamente dopo qualche istante di silenzio.
— Fin quando se trattava de produrre a Muran. El me sogno se fermava eà e no se immaginava a scampar come adri, inseguii daea maragia dea corporassion, mettendo in pericoeo e nostre mugeri, i nostri fioi… e nostre stesse vite.
— A Venexia no ghe gera nissun disposto a darne palanche nei esperimenti per ottenir astre de grande formato. A Firense podaremo finalmente provar a cambiar ea soda co a potassa, sercar ea giusta miscea zontando sodio, manganese e… — Si interruppe bruscamente, davanti al palmo della mano del fratello che si era alzata imperiosa per rimarcare l’inutilità di quell’ennesima discussione, ma che si era addolcita subito dopo in un gesto indefinito, fra la commiserazione e il perdono per quella scelta oramai irreversibile.
Grazie a Dio, avevano convinto mogli e figli a mettersi in viaggio ben prima di loro, che si erano dovuti trattenere a Venezia per coprire la fuga dei propri famigliari, asserendo che le donne e la prole erano andati a visitar parenti, quando invece li avevano preceduti, in quel luogo, da quasi un paio di settimane e ora li attendevano al sicuro, al di là del confine, in una casa nei pressi del castello.
Una dozzina di giorni che si erano rivelati provvidenzialmente preziosi. Nessuno dei due fratelli aveva messo in conto la possibilità di essere traditi e costretti a una fuga precipitosa, braccati come animali dalle canaglie al soldo della corporazione.
Una dabbenaggine che poteva costar cara, colpevoli di non aver preso in considerazione una simile eventualità, cedendo alle lusinghe sussurrate, a quelle nuove opportunità che si spalancavano davanti a loro, e ancor di più alle prospettive di ricco guadagno.
L’emissario fiorentino, non si poteva non ammetterlo, era stato abile. Si era presentato in bottega un giorno di settembre dell’anno prima e, senza che gli fosse stato richiesto, aveva iniziato a tessere le lodi del suo munifico signore. Quel Lorenzo de’ Medici, la cui fama aveva raggiunto ogni angolo del mondo. Un mecenate di tutte le arti, che si compiaceva dei risultati ottenuti, ma che – disse l’emissario – a ogni traguardo raggiunto proiettava lo sguardo ancora oltre, infaticabilmente alla ricerca di nuove eccellenze. Anch’egli un sognatore che tollerava i limiti naturali solo per poterli abbattere, realizzando ciò che l’immaginazione incessantemente gli suggeriva. E ciò che suggeriva, in quel tempo, riguardava quei due fratelli.
L’emissario spiegò cosa Lorenzo si aspettasse di poter realizzare con l’aiuto dei due maestri vetrai.
Seppur scettici, i veneziani lo ascoltarono rapiti dai modi cortesi e dall’eloquio dell’elegante individuo, ma via via che il progetto veniva illustrato e prendeva corpo, le perplessità lasciarono il campo allo stupore. I due fratelli avevano sgranato gli occhi scambiandosi occhiate inquiete, inspirando a fondo, increduli, e trattenendo il respiro.
Il maggiore dei due aveva preso a tormentarsi la barba sotto al mento, con gli occhi che vagavano nella stanza, mentre la mente si dannava cercando di artigliare indefinite ispirazioni che sfrecciavano come lampi inafferrabili in una stanza buia. Tentava affannosamente di mettere assieme le idee e ipotizzare, così su due piedi, come realizzare ciò che apparentemente era impossibile.
Fin da piccolo, suo padre gli aveva dimostrato con grande semplicità che l’uomo è portato a ritenere irrealizzabile ogni obiettivo per il quale non conosce, o non possiede, la tecnica necessaria per concretizzarlo, ma questo non significava che non esistesse un modo per rendere possibile ciò che apparentemente non lo è, e per farglielo comprendere aveva preso un uovo e gli aveva chiesto di farlo stare in equilibrio col vertice all’insù. Dopo averlo lasciato provare invano varie volte, il padre aveva preso l’uovo e con un movimento secco lo aveva sbattuto sul tavolo, frantumandone la base del guscio, mostrandogli così come l’uovo potesse stare in equilibrio.
Da allora “impossibile” era divenuta una parola che aveva perso quell’aura di perentorietà che rifiutava a priori l’esistenza di una soluzione a un problema. Questo assunto non presupponeva che per forza vi fosse una soluzione, tuttavia lo aveva portato a ritenere che fosse abbastanza probabile che ogni problema avesse almeno un modo per essere risolto.
Si trattava solo di individuarlo e talvolta, come gli aveva insegnato il padre, risultava molto più semplice di quanto si potesse immaginare.
Il fratello maggiore rimase ad arrovellarsi in uno stato di eccitazione per qualche istante, poi fu sorpreso dall’angoscia che si fece strada, man mano che scartava ogni ipotesi di lavoro, e si rendeva sempre più consapevole sia delle difficoltà tecniche della pretesa, sia dell’enorme costo che si sarebbe dovuto sostenere per sperimentare come realizzare ciò che era loro richiesto.
Affranto e svuotato dallo sforzo, espirò, mise una mano sulla bocca e sconfitto scrollò il capo gravemente, riportando lo sguardo triste sull’emissario. Quest’ultimo non si perse d’animo, infilò una mano nell’abito e, dopo aver frugato al suo interno, estrasse quattro borselli di morbido cuoio che posò sul tavolo di fronte a sé.
Disse che il suo padrone era così convinto di poter attuare il suo disegno visionario che era pronto a spendere qualunque cifra. Quello che aveva messo sul tavolo era solo un piccolo acconto, quindi si alzò e congedandosi comunicò che sarebbe passato il giorno successivo per avere la loro risposta.
I due fratelli lo seguirono con lo sguardo finché non lo videro scomparire dietro alla porta che si chiudeva alle sue spalle.
Senza scambiare una parola, il più giovane si alzò, sciolse i lacci di uno dei borselli e ne vuotò il contenuto sul tavolo. Venticinque fiorini d’oro tintinnarono disponendosi a casaccio sulle doghe di legno. Dopo averli contati, aprì gli altri borselli, ciascuno dei quali conteneva un’identica quantità di denaro.
Cento fiorini d’oro di acconto. Una somma di per sé enorme, ma forse insignificante per i costi che si sarebbero dovuti sostenere. D’altra parte, sottolineò il fratello maggiore, l’emissario aveva specificato che si trattava di un “piccolo acconto”. Entusiasmati dalla prospettiva di lavorare su un progetto di tale portata, concessero un giorno di libertà ai loro operai, commessi e apprendisti e chiusero bottega per andarlo a riferire alle loro mogli e con loro, quella sera, fecero festa.
Il giorno successivo l’emissario si ripresentò e i due fratelli gli comunicarono che accettavano la proposta del suo illustre signore. Il fiorentino se ne rallegrò e li ringraziò, assicurando loro che, in pochissimo tempo, avrebbe organizzato a Firenze un’accoglienza adeguata ad alloggiare le due famiglie e che, nel frattempo, avrebbero attrezzato l’officina secondo le loro istruzioni.
— Trasferirse a Firense? — aveva domandato sorpreso il maggiore dei due fratelli vetrai, conscio di parlare anche per l’altro, pure lui indubbiamente colto alla sprovvista.
L’emissario se ne scusò spiegando che non ne aveva fatto cenno durante il precedente incontro, dandolo per scontato, poiché ogni maestro ingaggiato dal suo signore doveva necessariamente lavorare a Firenze, affinché fosse possibile verificarne costantemente i progressi. Una condizione ancor più imprescindibile data l’importanza del progetto che desiderava commissionare, per la cui realizzazione sarebbe stata indispensabile l’opera collaborativa di maestri appartenenti ad altre Arti.
Il fratello maggiore replicò spiegando che lo statuto della corporazione dei vetrai di Murano imponeva rigidamente che si preservassero i segreti di lavorazione e impediva, senza eccezioni, che si potessero aprire fornaci veneziane all’estero. Ne conseguiva che per trasferirsi a Firenze avrebbero dovuto fuggire, senza poter più farvi ritorno, ma soprattutto, avrebbero messo in pericolo le loro stesse vite e quelle dei loro familiari.
L’emissario ancora una volta non si perse d’animo. Non aveva necessità di sottolineare che Firenze possedeva fornaci di livello paragonabile a quelle veneziane di cui era temibile concorrente, si limitò invece a evidenziare che già da tempo diversi maestri veneziani si erano trasferiti, armi e bagagli, a Firenze e che a nessuno di loro era stato torto un capello. Si trattava solo di uscire dalla città con “discrezione”.
Con “discrezione” aveva detto. E aveva spiegato come farlo, un disegno già ben pianificato, sicché tutto era sembrato semplice, estremamente prudente e rassicurante, mentre non lo fu affatto.
Venezia aveva avide orecchie ovunque e loro, pur essendone consapevoli, lo avevano trascurato. Gli ambasciatori veneziani, inviati presso le corti di tutto il mondo, trasmettevano resoconti particolareggiati su tutto quanto potesse essere d’interesse per gli affari della potente Repubblica.
E così tutto si complicò, costringendo le donne con la prole al seguito ad affrontare un viaggio durissimo, travestite da uomini per uscire dalla città senza dare nell’occhio, mentre i due fratelli, rimasti per dare il tempo alle mogli di mettersi al sicuro, dovettero imbarcarsi in una fuga precipitosa, braccati da individui spietati, agli ordini di una corporazione che non poteva tollerare che i segreti di produzione fossero rivelati ai concorrenti di altre nazioni.
Fortunatamente i fuggitivi erano riusciti a seminare gli inseguitori e, finalmente, arrivati nei pressi del castello di Finale, potevano tirare un sospiro di sollievo e ricongiungersi ai propri familiari che li attendevano in quella casa appena oltre il confine.
Ormai erano al sicuro. Quelle canaglie non li avrebbero più agguantati e, se anche vi fossero riusciti, i soldati della guarnigione di stanza nel castello li avrebbero protetti, finché non fossero stati raggiunti dalla scorta che il signore di Firenze aveva mandato loro incontro, munita di tutti i lasciapassare necessari.
Accelerando il passo, in pochi minuti raggiunsero la casa dove li attendevano mogli e figli, mentre la cortina nebbiosa, indifferente alle loro sorti, si addensava a ogni istante, divenendo progressivamente sempre più impenetrabile.
Bussarono alla porta, respirando affannosamente. Quell’ultimo tratto, percorso quasi di corsa, li aveva stremati.
Al di là dell’uscio si percepì un moto di agitazione e le voci cristalline dei bimbi che si scatenavano eccitate.
Una voce di donna attraversò il legno massiccio della porta. Domandò chi fossero.
Il fratello minore, rallegrandosi, riconobbe la propria moglie e benché il cuore gli scoppiasse nel petto dalla gioia, togliendogli il respiro, riuscì a chiamarla per nome e ad assicurarle che era proprio lui, suo marito.
La donna non perse un istante, rimosse la tavola che sbarrava la porta e l’aprì, gettandosi nelle braccia di lui, soffocandolo assieme ai suoi figli che si strinsero al padre con tale trasporto che quasi gli fecero perdere l’equilibrio.
Il fratello maggiore non poté far altro che girare intorno a quell’ammasso di braccia e gambe che si agitavano sulla soglia e, finalmente, riabbracciò, a sua volta, moglie e figli.
Una volta spentesi le grida di entusiasmo, entrarono. La porta fu nuovamente sbarrata e gli uomini furono fatti accomodare a tavola, dove in poco tempo fu servita una zuppa di verdure, guarnita da generosi pezzi di pane, che li rigenerò.
Trascorsero la serata raccontando i fatti più salienti degli ultimi giorni, le fatiche e le insidie del viaggio, come si erano liberati della marmaglia che li inseguiva, finché, completamente esausti, dopo aver messo a letto la prole, seguirono le mogli al piano di sopra, dove trovarono morbidi pagliericci ad accoglierli.
Si distesero e in pochi istanti si addormentarono fra le braccia delle donne, mentre all’esterno la nebbia aveva avvolto ogni cosa fra le sue spire impenetrabili.
Dopo appena qualche ora, il riposo venne interrotto bruscamente.
Nel cuore della notte furono svegliati da pesanti martellate che percuotevano gli scuri alle finestre da ogni lato della casa.
All’interno rimbombava tutto, gettandoli nel panico. Le donne e i bambini gridavano terrorizzati, mentre gli uomini svegliatisi di soprassalto, a tentoni, cercarono di agguantare una candela per illuminare la stanza.
Dopo qualche tempo, il frastuono cessò all’improvviso, com’era iniziato. Per lunghi istanti non si udì alcun rumore. Se non giusto il mormorio dei fanciulli che si erano stretti attorno ai genitori al centro della camera. Abbracciati gli uni agli altri.
Con stizza il fratello maggiore ingiunse a tutti di fare silenzio assoluto e contemporaneamente tese le orecchie per percepire anche il più debole segnale di pericolo.
Il cuore gli batteva forte in gola, agitato, con le tempie che pulsavano dolorosamente.
Nessuno osò respirare, finché non udirono alcuni tonfi sordi sul tetto e poco dopo il crepitio delle fiamme che avevano iniziato a divorarlo.
Colti dal terrore, scesero al piano di sotto, alcuni ruzzolarono giù dalle scale, rischiando di rompersi l’osso del collo.
Concitatamente arrivarono alla porta, tolsero l’asse che la sbarrava e tentarono di aprirla. Non ci fu verso di riuscirci. Gli uomini spinsero dapprima con le mani, poi cercarono di buttarla giù a spallate, finché con orrore non si accorsero che da sotto e dalle pareti laterali cominciava a filtrare il fumo, mentre l’iniziale crepitio al piano di sopra si era trasformato, in poco tempo, in un ruggito rovente.
La porta doveva essere stata inchiodata dall’esterno per impedire loro di fuggire e così doveva essere per ogni finestra.
Disperati tentarono ugualmente, ma non riuscirono a spalancarle.
Porta e finestre erano state pesantemente sbarrate dall’esterno.
Le donne gridavano disperate, i bambini piangevano e alcuni iniziarono a tossire. I due fratelli in preda al panico giravano intorno, incapaci di trovare una via d’uscita.
Il maggiore ruppe gli indugi e si scagliò nuovamente contro la porta, ma fu respinto e rimbalzò indietro con la spalla dolorante. Mentre si massaggiava cercando di lenire il dolore, circondato da volute di fumo e urla terrorizzate che gli impedivano di ragionare, gli occhi irritati gli caddero su un’accetta appesa a lato del camino.
La speranza si riaccese e per il sollievo inspirò, inalando aria ormai avvelenata dal fumo. Tossendo, raggiunse il camino e afferrò l’attrezzo, si girò e si diresse nuovamente verso la porta.
Si era coperto il naso con la manica della tunica, mentre gli occhi lacrimavano e non riusciva a smettere di tossire.
A un tratto si rese conto che attorno a sé le grida si erano spente, chi non era ancora svenuto tossiva incessantemente.
Sapeva che gli restava poco tempo, prima di crollare a terra come gli altri. Si gettò sulla porta e iniziò a percuoterla con l’accetta scagliata con tutta la forza che aveva. Due, tre, quattro volte. Le schegge di legno schizzavano via come frecce impazzite, aprendo un pertugio sempre più largo.
Non ebbe la forza per un quinto colpo. Si accasciò a terra e l’accetta gli scivolò dalle mani, avvolta dal fumo che ormai aveva invaso tutta la stanza. Al piano di sopra, sinistri scricchiolii annunziavano che alcune travi, indebolite dalle fiamme, erano in procinto di cedere, trascinandosi dietro una parte del tetto.
Un drappello di guardie se ne stava ammassato sugli spalti del castello. Il chiarore delle fiamme riempiva i loro sguardi impotenti.
Il comandante era al loro fianco; gli occhi fissi non tradivano emozioni.
Lo avevano tirato giù dal letto, non appena il silenzio della notte era stato spazzato via da potenti colpi di martello.
Non avevano potuto intervenire, la nebbia maledetta aveva impedito loro di individuare la causa e l’origine di quel frastuono, cessato improvvisamente così com’era comparso, finché le fiamme non si erano levate rabbiose a dissipare il buio della notte, fra le grida di donne e fanciulli che straziavano il cuore. Troppo tardi.
Sull’argine del fiume, a circa duecento braccia di distanza, una quindicina di uomini osservava il falò con la serenità contemplativa con cui si ammirava un capolavoro. In questo caso si trattava non di un dipinto o un’aggraziata statua, ma, a parer loro, di equilibrata e sacrosanta giustizia.
Lievemente in disparte se ne stava immobile un uomo alto, con un cappello a larghe falde, ornato dalla piuma di un fagiano. Lo sguardo glaciale su quello che, a distanza, poteva sembrare un covone di paglia dato alle fiamme.
Là dentro si stavano consumando le vite di due abili maestri dell’arte, le loro mogli e sette fanciulli, il più grande dei quali aveva solo nove anni.
Il bolognese Andrea Galliccioli, detto il Gallo, si domandò perché mai avesse accettato quel lavoro. Si lisciò la barba e con la punta del pollice toccò pensieroso il labbro inferiore.
Come avrebbe reagito il suo maestro Guido Antonio di Luca se avesse saputo che un suo allievo aveva preso parte a imprese così spietate e senza onore?
Specifiche
- Genere: Giallo
- Collana: I gialli Damster
- Formato: 14x20 cm
- Pagine: 650
- ISBN: 978-88-6810-507-5
- Anno pubblicazione: 2022
- Prezzo copertina:: 22
- Esiste la versione ebook?: no